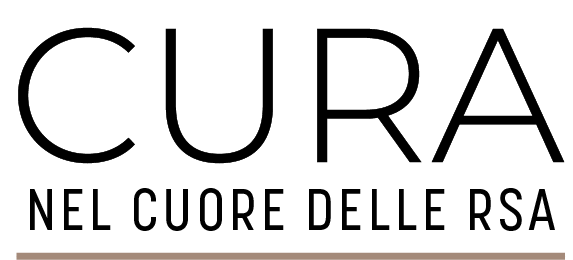Chi arriva al ricovero in una Casa di Riposo è già sulla strada della mancanza di autosufficienza, o per lo meno presenta una debolezza fisica e mentale che si traduce in decadimento delle capacità motorie, della vista, dell’udito, dell’attività cognitiva. E’ dunque una situazione di estrema vulnerabilità a cui deve far fronte l’operatore che l’avrà in cura; purtroppo questo gli conferisce un potere quasi assoluto, che può degenerare in sopraffazione e prevaricazione. Abbiamo tutti visto i video che documentano i maltrattamenti fisici e verbali che si sono verificati in alcune di queste strutture. Senza arrivare a questi eccessi, la condotta del personale può essere ugualmente nociva, tendendo a diminuire l’autostima e a minare la dignità dell’anziano.
Intanto c’è già il contesto, tipico di un reparto ospedaliero, a demotivare gli ospiti: lo scarso contatto col mondo esterno, limitato agli orari di visita, l’ambiente anonimo, asettico e spersonalizzato, gli orari rigidi e penalizzanti, la privacy e il senso del pudore violati per necessità assistenziali. Se a questa condizione si aggiungono l’inattività e la dipendenza quasi totale dal personale, e quindi la perdita del senso di responsabilità, non è raro che si possa incorrere in specifici disturbi psicologici. Di “nevrosi istituzionale”, come logica reazione a un ambiente privo di stimoli sociali e affettivi, aveva già parlato nel 1959 lo studioso Robert Burton, definendone i sintomi in stati di apatia, perdita d’interesse e di contatto col mondo esterno, sottomissione e mancanza d’ iniziativa, chiusura in se stessi.
Se un corretto approccio da parte degli operatori può fare la differenza, valorizzando le capacità residue dell’anziano in modo da rafforzarle, ancora più importante può essere il loro atteggiamento nei confronti delle persone affette da demenza, verso le quali, di fronte a una presunta impossibilità di recupero, si è spesso tentati di effettuare un contenimento fisico o farmacologico. Le ultime tendenze psicologiche, invece, investono sul principio del rispetto che va concesso a qualsiasi persona umana, indipendentemente dalla sua malattia o disabilità. In questa corrente s’inserisce Tom Kitwood, che ha ideato una teoria sulle modalità relazionali adottate verso gli anziani, denominata “psicologia sociale maligna”. E’ un vero e proprio decalogo l’elenco degli atteggiamenti dannosi che possono incidere pesantemente con effetti invalidanti su persone già avviate verso il deterioramento cognitivo, fino a produrre vissuti di spersonalizzazione.
Si parte dall’inganno che, con astuzie e bugie, può facilitare l’obbedienza, per arrivare all’esautorazione che, al fine di velocizzare i tempi, toglie alla persona l’esecuzione di compiti che sarebbe ancora in grado di svolgere. Caratteristica è l’infantilizzazione , esercitata in toni di voce e minacce adatte ai bambini, che può culminare nell’intimidazione, dove si tende a spaventare il paziente con diagnosi mediche o psicologiche, ma anche con aggressioni verbali e fisiche. Trattare l’anziano come un demente fa parte dell’etichettatura e tradurlo in un oggetto da biasimare e da escludere diventa stigmatizzazione. Non considerare che il paziente ha un funzionamento mentale più lento può produrre un distanziamento interpersonale, non riconoscere i suoi sentimenti e i suoi pensieri produce invalidamento, che condurrà all’esilio, se lo si estromette, in modo fisico e psichico, dall’ambiente sociale circostante, e culminerà nell’oggettivazione, che l’avrà definitivamente trasformato da persona in oggetto.
Come evitare di incorrere in questi “peccati” nel trattamento assistenziale? Occorre rendersi conto dei bisogni dell’altro e comprenderne il vissuto, non focalizzarsi sul deficit ma cercare di attivare l’efficienza della persona, sostenere il valore dell’individuo e la sua autonomia. Ma sarà utile anche una formazione permanente degli operatori per esorcizzare il perpetuarsi di questo decalogo.