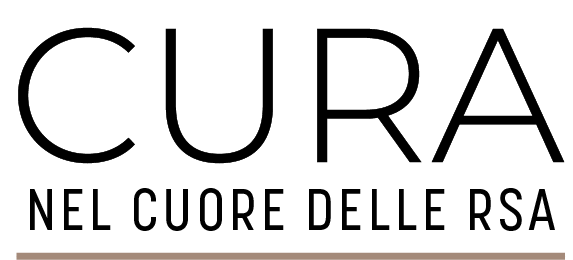Kierkegaard è stato “riscoperto” appena a partire dagli anni Trenta del Novecento, per opera del teologo protestante Karl Barth che ha messo in evidenza, attraverso una rilettura di Kierkegaard, i contenuti inquietanti presenti nel messaggio cristiano.
Poi l’esistenzialismo europeo – da Heidegger a Sartre – ha visto in lui uno dei suoi padri ideali. E all’interno di un più vasto orizzonte artistico – Kafka e Gide in letteratura, Dreyer e Bergman nel cinema – le sue opere hanno costituito un punto di riferimento e di ispirazione. Insomma una parte notevole del pensiero e dell’arte contemporanea ha scorto in lui la testimonianza di un travaglio esistenziale che non ha uguali.
Søren Aabye Kierkegaard [d’ora in poi K.] nacque a Copenhagen il 5 maggio 1813. Educato da un padre anziano in un clima di religiosità severa, è cresciuto in un ambiente familiare austero, segnato dal pensiero ossessivo della colpa e della morte. Nel suo sterminato Diario (più di 2000 pagine!) così si confessa: «Io non ho mai saputo cosa significhi essere bambino… Entravo nella vita favorito sia per le doti spirituali che per l’esistenza materiale, nutrivo fiducia che avrei potuto realizzare quello che volevo, eccetto una cosa: liberarmi dalla tristezza, che mi tiene ancora avvinto nelle sue grandi reti.» Da ciò il carattere meditativo e malinconico del giovane Søren, aggravato dal suo aspetto fisico, gracile e sgraziato, che fu anche oggetto di scherno da parte di un giornale satirico. D’altra parte, però, egli godeva di stima e simpatia presso amici e conoscenti per il suo brio e la sua superiorità intellettuale.
Qualche anno prima della laurea in teologia nel 1840, era iniziata la tormentata e triste vicenda del suo amore per la bella Regine Olsen, appena diciassettenne, con la quale poi inspiegabilmente ruppe il fidanzamento poco prima delle nozze. Studiosi e biografi “indiscreti” si sono interrogati senza esito sull’episodio, sulla base di vaghi riferimenti nel Diario e delle parole che avrebbe detto sul letto di morte: «Sono stato costretto a portare una spina nelle carni.»
Dopo la rinuncia al matrimonio, seguì quella alla carriera di pastore. Anzi, con la chiesa luterana danese K. polemizzò aspramente, denunciandone la corruzione e il tradimento del messaggio di Cristo.
Da allora la creazione letteraria divenne per K. una necessità vitale: per lui “vivere” coincideva ormai con lo “scrivere”. La mole della sua opera è enorme, e si concentra in poco più di un decennio, dal 1843 al 1855, anno della sua morte. Negli scritti la forma della comunicazione è indiretta: non si tratta, avverte K., di trasmettere una dottrina, ma di trasformare l’esistenza di chi legge; i suoi maestri “senza scrittura” sono Socrate e Cristo. Qui sarà possibile solo accennare in sintesi a qualche “frutto” importante della sua sofferta riflessione.
Aut-Aut (Enter-Eller in danese), il suo capolavoro, si apre con un monito: «Amico mio, te l’ho già detto e ora te lo ripeto, anzi te lo grido: o questo o quello, enter-eller!» O la vita estetica o la vita etica: l’una esclude l’altra. L’esteta vive nell’immediato, il suo rapporto con l’esistenza si realizza nel godimento e nella “rappresentazione” del godimento; la sua sfera è il gioco e l’immaginazione, la sua vita è “teatro”. K. si serve di tre figure emblematiche per rappresentare l’estetico. Due sono miti letterari: il Don Giovanni (immortalato dalla musica di Mozart, che K. amava) e il Faust di Goethe. La terza figura è Johannes, che si colloca al polo opposto a Don Giovanni: il suo Diario di un seduttore [per cui K. divenne celebre] narra la trama sottile in cui egli avvolge Cordelia, anche lei diciassettenne come Regine, per conquistarla e poi abbandonarla. Qui l’eros passa in secondo piano: Johannes non gode del possesso, anzi lo evita e lo rimanda, in quanto la riuscita della seduzione metterebbe fine al piacere dell’immaginazione. La figura di Johannes rappresenta la vita estetica nel suo grado più raffinato. Nell’eroe estetico di K. si è vista anche la disperata espressione dell’amore romantico che cerca “l’infinito nel finito”.
Nella seconda parte del saggio, l’assessore Wilhelm – buon marito e padre, funzionario esemplare – incarna , in contrapposizione, l’uomo etico e difende, in una serie di lettere, la sua scelta di vita dalle critiche romantiche dell’esteta seduttore.
Ma l’esistenza umana si può realizzare anche in un terzo stadio di vita: quello religioso. Sentirsi, come essere umano, “colpevole” e “disperato”: ecco lo stato d’animo che può indurre al salto nella fede. Pochi mesi dopo Aut-Aut uscì Timore e Tremore, che si rifà all’episodio biblico del sacrificio di Isacco, dove Abramo obbedisce per fede al comando divino contro ogni morale umana e contro se stesso, cioè l’amore per il suo unico figlio. La sua scelta “disumana” porta Abramo nella solitudine esistenziale, dove non ci sono regole né voci amiche: “nella fede non si entra in compagnia”. La fede per K. è paradosso e scandalo: ben lungi dal garantire tranquillità e certezze, mette drammaticamente il singolo di fronte a se stesso, alla salvezza o alla perdizione. É questo il cristianesimo tragico di K.
Da ciò l’angoscia, sintomo di una mancanza e incompletezza profonde dell’essere umano: quella sensazione inafferrabile di ansia, che fece scrivere a Leopardi rivolgendosi alla luna “io venia pien d’angoscia a rimirarti”. K. la mette sotto la lente della sua acuta sensibilità nello scritto successivo, partendo dalla “sconvolgente scoperta della libertà, in quanto potenzialità del possibile”, in cui l’uomo scorge qualcosa di più minaccioso del reale. «La possibilità – scrive K. ne Il concetto di angoscia – è la più pesante delle categorie… L’uomo esalterà la realtà, anche quando pesa grave su di lui, perchè egli si ricorderà che essa è molto più leggera della possibilità.» La possibilità, terribile frutto della libertà costitutiva dell’essere umano, implica il divenire altro, al limite il non-essere, il nulla.
K. anticipa Kafka. Ora, lo stato d’animo a cui alla fine approda l’esteta e quello preliminare al salto nel buio della fede è comunque la disperazione; e può succedere che essa alberghi anche, in certi momenti, nel cuore dell’assessore Wilhelm. E alla disperazione K. dedica (prima di Freud) un mirabile saggio di analisi psicologica, che mostra l’impossibilità per l’individuo di convivere serenamente con se stesso: La malattia mortale. Disperazione non di qualcosa, bensì di se stesso: l’individuo avverte il proprio limite e insieme scopre, con disperazione, che non può evadere da se stesso, non può abbandonare il suo “essere un singolo”, pena la perdita dell’individualità (disperdendosi nel sociale). É questa la malattia mortale, mortale non perchè conduce alla morte, ma perchè consiste nel vivere, ogni giorno, la propria incapacità di vivere.
K. si spense l’11 novembre 1855, a soli 42 anni. Sulla sua tomba avrebbe voluto questo semplice epitaffio: “Qui giace un individuo”. Dovettero passare vent’anni prima che nella sua Copenhagen gli venisse eretto un monumento, su cui sono incisi versetti retorici.